Recensione - "Autostop con Buddha", W. Ferguson
Autostop
con Buddha (edito
da Feltrinelli in “Universale economica”, 2018), è il romanzo con cui esordisce
il canadese Will Ferguson nel genere della narrativa da viaggio. Con la sua “corporatura da orso e lo zaino ingombrante”
fa un break dal suo lavoro di docente inglese in Giappone, dove ci resta per
cinque anni. Con un po’ d’incoscienza e col suo scarso senso dell’orientamento
decide di inseguire la rosea scia del Sakura
Senzen, il “Fronte dei fiori di ciliegio” che esplode nella terra nipponica
all’inizio della primavera.
Ferguson si sposta
in autostop da una punta all’altra del Giappone, da Sud a Nord, da Capo Sata a
Capo Soya, attraversando le quattro grandi isole del continente: Kyushu,
Shikoku, Honshu spingendosi sino a Hokkaido, “dove finisce il Giappone”.
Diversamente da
altri viaggiatori solitari che lo hanno preceduto - il compositore di haiku per
eccellenza Matsuo Basho, Lesly Downer, Alan Booth -, Ferguson decide di procedere in solitaria sì, ma con
l’obbiettivo di non “viaggiare tra i
giapponesi, ma insieme a loro”.
Autostop
con Buddha è una
storia che schiude altre storie, quelle che s’incrociano col pollice dello scrittore e che avranno sempre un nome, un cognome e una
contraddizione. Ciò che ne vien fuori è
un vero e proprio collage fatto di fotografie diverse che daranno una
panoramica sorprendentemente coerente di ciò che il Giappone è, ma soprattutto di
ciò che il Giappone è per Will.
Dai suoi confini Will ne resterà sempre fuori: è il destino del gaijin che non vuol dire semplicemente “straniero”, bensì vela – ma poi neanche troppo – una sorta di esclusione non dichiarata verso il forestiero da parte dei giapponesi. È una percezione che in Will assume le vesti di una sofferta consapevolezza perché Ferguson ama il Giappone e questo romanzo fornisce, in qualche modo, l’occasione di comprendere meglio quel senso di disorientamento che invece prova quando è in Canada, nel suo Paese d’origine e che racconta in “Why I hate Canadians”.
Questa terra si
racconta attraverso i ricordi ancora vividi dei veterani che Will incontra, il
dolore stretto in una morsa nel ricordare gli eventi traumatici di Hiroshima e
Nagasaki, le leggende, i templi, i riti e un’appartenenza eccessivamente
nazionalista, “è la nazione numero uno al
mondo. Le aziende giapponesi sono fortissime. I prodotti giapponesi sono i
migliori al mondo”, seppur a parlarne resta “una nazione piccola e povera”, con consenso generale ovviamente.
La sua penna ha due
enormi potenzialità: il cuore e l’ironia, a tratti pungente di sarcasmo, ma che
lui utilizza in maniera sapienziale.

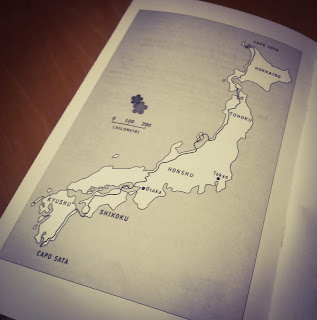



Commenti
Posta un commento